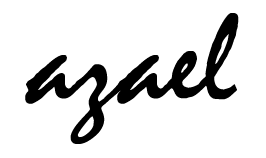Un paio di anni fa, all’imbocco dello stadio Panathinaiko di Atene, lo sguardo fisso sullo sterno dell’Arcangelo Gabriele che vedevo chiaramente stagliato nel grigio azzurro del cielo, stavo per percorrere gli ultimi duecento metri della mia prima maratona.
Una roba devastante e bellissima. Bellissima e tremenda. Uno sbocco di sangue, un’agonia di vesciche e sguardi epici lanciati ai cassonetti della periferia di Atene.
Io ho iniziato a correre tardi, intorno ai 40 anni, perché a 40 anni – se non hai già preso a drogarti – a un certo punto, inizi a correre. A 40 anni per la prima volta ti dicono che sei un adulto, ma proprio adulto-adulto, come gli omini vestiti da adulti, quelli che da ragazzino ti sembravano proprio un’altra specie, quella dei tuoi genitori, quella dei genitori di tutti, i patriarchi dell’umanità. E allora non inizi esattamente a correre, inizi a scappare.
Dopo nemmeno due anni dalla mia prima maratona sono andato in Kenya, a vedere come fanno i keniani.
Sono andato in Kenya, ma non al mare, negli altipiani, al confine con niente. Insieme a un manipolo di esaltati come me, quelli della società alla quale sono iscritto – ASD Purosangue Athletics – sono andato in un villaggio, Iten, in cui ogni anno vanno tutti i più forti atleti del mondo, vanno ad allenarsi con i keniani, i keniani che vincono tutte le gare di corsa del pianeta. E ci vanno anche tanti amatori, perché ormai è diventata una meta simbolo per tutti quelli che amano la corsa.

Siamo stati in un centro di allenamento – l’High Altitude Training Centre – un bel posto, con pratino all’inglese, piscina, palestra, mensa. Un bel posto in cui però si fa una vita decisamente spartana, in camerette da casa dello studente, cibo semplice e sveglia alle 5.30. È un posto pieno di atleti, di campioni provenienti da ogni parte del mondo. E così può capitare di dover fare la fila alla fontanella per lavarti i panni dietro a una campionessa europea dei 5.000m, o di smezzare una discutibile zuppa di carote con un campione del mondo di qualsiasi cosa.
Dato che non è educato andare in Kenya a mani vuote, con il manipolo di esaltati abbiamo approfittato per portare qualche migliaio di scarpe ai mini-keniani, per far sì che possano continuare a umiliarci in tutte le olimpiadi da qui ai prossimi 70 anni. Siamo andati nelle scuole e abbiamo organizzato delle gare di corsa, mettendo in palio tutte quelle scarpe, abbiamo tirato su le transenne, l’arco gonfiabile dell’arrivo e potato alberi per ricavare percorsi serissimi per i bimbetti scalzi più veloci dell’universo.

Per tutto il tempo che siamo stati lì abbiamo corso, tutti i giorni, anche due volte al giorno, perché a Iten non c’è altro da fare. Si corre sempre, corrono tutti. I keniani, a Iten, corrono sempre.
Corrono ma non necessariamente si divertono, corrono seriamente.
Ma perché i kenyani corrono così forte? Perché proprio loro? Perché proprio qui? Qual è il segreto di Iten? Qual è il segreto dei keniani? Come si diventa keniani? Qual è il segreto dell’immortalità? Perché esiste la vita sulla terra?
Il Kenya, quando passi dall’inferno di Nairobi agli altipiani, non è savana, è il Trentino: verde, rigoglioso, in salita. Sarà che son cresciuto a pane e Quark, ma io il Kenya me lo immaginavo diverso.

Poi arrivi a Iten e trovi l’Africa.
La terra rossa, le baracche di lamiera e merda di vacca. Pare che la merda di vacca sia eccezionale per impastare la calce.
A Iten trovi i bambini.
I bambini.
Una marea di bambini.
A Iten i bambini salutano sempre – in Italia lo fanno solo quelli che poi muoiono nei fatti di cronaca – ridono e salutano, ti guardano con degli occhi che sembrano lanciare fasci di luce in grado di farti i raggi.
Vanno a scuola, vivono a scuola, stanno a scuola 27 ore al giorno
Sembra che le scuole siano l’unica cosa seria, in Kenya.
A Iten tutto è povero, ma la ricchezza non sta lì a fartelo pesare.
A Iten la povertà non è una condizione, è un luogo.
Iten è una strada, le persone vivono chissà dove, in campagna, in posti raggiungibili con stradine rosse e impolverate.
In Kenya le strade non portano nei posti, portano in altre strade, e poi altre ancora, per sempre, fino a quando ti perdi.
I sud del mondo si assomigliano tutti. Ma alcuni sud, come questo, sembrano pregustare la nostalgia che sarà, quella che si potrà sentire da Londra, Milano, Francoforte, da una qualsiasi periferia organizzatissima e moribonda. Una nostalgia fatta di mancanza di spazio e di terra. Eppure non sarà nostalgia delle cose semplici, qui niente è semplice, nessuno sguardo è ingenuo.
I keniani sanno dell’esistenza del mondo, è il mondo a non sapere davvero dell’esistenza dei keniani.
I bambini di Iten sono come noi da vecchi, corrono, scappano, scappiamo, per avere un’altra opportunità.
Si corre, si suda, ci si sveglia prestissimo, si fanno cose ridicole come vestirsi di fucsia con calzamaglie pornografiche, ma seriamente, come se fosse una cosa vitale.
Se un alieno venisse per capire cosa succede nelle strade delle nostre città, alle prime luci dell’alba, e a Iten, in ogni ora del giorno e della notte, penserebbe che qualcuno stia inseguendo questi branchi di signori attempati, e questi ragazzi leggerissimi che corrono continuamente, forse un mostro con un’ascia, la vita, una minaccia misteriosa.
Qualche anno fa, durante la mia prima maratona, intorno al trentottesimo chilometro, nella periferia di Atene, dopo tre ore e passa, con le vesciche sotto i due alluci, le anche che scrocchiavano come fette biscottate, mi si è presentato in testa un pensiero chiarissimo: ma cosa cazzo sto facendo? Perché stiamo correndo tutti? Ma non lo vedete che sembriamo dei pazzi? Da cosa scappate? Da cosa scappiamo? Chi ci sarà ad aspettarci all’arrivo? Ci sarà ancora un arrivo quando arriveremo noi? Saremo felici?
Saremo felici?